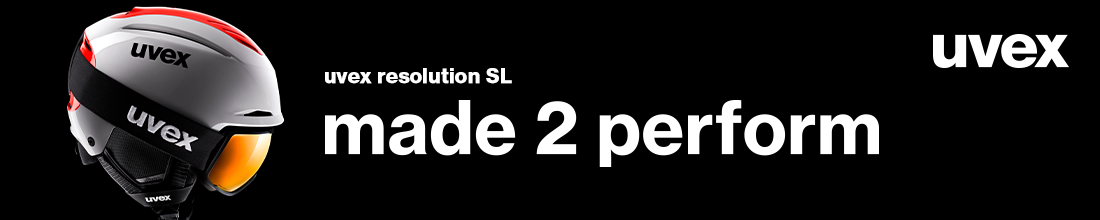Edizione storica, quella norvegese dei Giochi invernali datata 1952 (qui la puntata sull’ingresso dello sci alpino ai Giochi Invernali, nel 1936). E per diversi motivi: gli sport di ghiaccio e neve trovano nel Paese scandinavo (nell’assegnazione, Oslo s’impone a Cortina) il loro habitat naturale; per la prima volta (seguirò poi Pechino nel 2022, 70 anni dopo) è una capitale a ospitare la rassegna olimpica; e per la prima volta le prove di sci alpino si svolgono a più di 100 chilometri dalla città ospitante.
Tornano in gara, dopo l’esclusione post-bellica, Germania (formalmente unificata, ma senza di fatto atleti della Germania Orientale) e Giappone; non ci sono le due Coree, nel pieno del loro conflitto fratricida, né l’Unione Sovietica (che tornerà nella famiglia olimpica pochi mesi dopo, ai Giochi estivi di Helsinki); arrivano le prime medaglie italiane (e saranno le uniche dell’intera spedizione) nello sci alpino.
Senza dimenticare che è questa la prima edizione in cui viene acceso il tripode olimpico: a compiere il sacro rito, Eigil Nansen, nipote del celebre esploratore Fridjof Nansen, che nel 1898 aveva attraversato la Groenlandia sugli sci. Sono 694 (di cui 109 donne) gli atleti che gareggiano in sei discipline e 22 prove dal 14 al 25 febbraio: fanno il loro esordio una gara di fondo di 10 chilometri femminile (vinta dalla canadese Wideman) e gli slalom giganti maschili e femminili, invece della combinata.
A dominare il medagliere proprio la Norvegia (16 medaglie, di cui sette ori) davanti agli Stati Uniti (undici, con quattro ori). Nello sci impressiona Stein Eriksen, il campione di casa oro nel gigante e argento nello speciale che poi, una volta professionista negli Stati Uniti, sarà l’ideatore del freestyle, inserito definitivamente nel programma olimpico ad Albertville 1992. Tra le donne, fa doppietta negli slalom la diciannovenne Andrea Mead Lawrence, mentre nel fondo emerge il talento del ventisettenne finlandese Veikko Hakulinen, che trionfa nella 50 chilometri: in carriera vincerà sette medaglie olimpiche (di cui tre ori) e ancora trentanovenne, a Innsbruck 1964, sarà in gara ma… nel biathlon!

L’Italia schiera 33 atleti, di cui cinque donne e, come dicevamo, fa per la prima volta bottino nello sci alpino. Se l’oro di Zeno Colò nella discesa libera corona una carriera straordinaria, ma fino ad allora avara di soddisfazioni a livello olimpico (e l’abetonese chiuderà quarto in speciale e gigante!), a sorprendere fu il terzo posto (davanti alla Seghi) in discesa libera di Giuliana Minuzzo, ventenne veneta di Vallorana, vicino Marostica, cresciuta però sugli sci a Cervinia, in Val d’Aosta.
Quattro anni dopo, con il cognome da sposata, Chenal, diventerà la prima donna a leggere il giuramento degli atleti, in occasione dei Giochi di Cortina (dove sarà quarta sia in discesa che in speciale, e terza nella combinata, valida però solo per la rassegna iridata). Ma Minuzzo Chenal saprà tornare sul podio olimpico a Squaw Valley, nel 1960, chiudendo al terzo posto in gigante; mezzo secolo più tardi la ritroveremo protagonista protagonista della cerimonia d’apertura dei Giochi di Torino 2006, reggendo la bandiera olimpica su cui giureranno lo sciatore Giorgio Rocca e il giudice Fabio Bianchetti.

«Ho sentito che la vittoria non mi poteva sfuggire» . Sanno di liberazione, le parole che Zeno Colò consegna a cronisti e tifosi al termine della discesa libera che a Norefjell (a un centinaio di chilometri da Oslo), gli regala il primo (e unico) oro olimpico della sua carriera. Zeno cancella lo zero, è lo stilema che resta nelle orecchie dopo l’impresa: perché oltre a riempire finalmente la casella dei titoli olimpici nel suo personale palmarès , quello del trentunenne abetonese è il primo oro olimpico nella storia dello sci alpino, e ancora l’unico conquistato da un italiano nella discesa libera maschile.
Che Colò fosse a quel tempo il più forte sciatore al mondo in pochi erano disposti a metterlo in discussione. Ma la fortuna, la tensione, le piste, ai Giochi olimpici, lo avevano fino a quel momento tradito: basti pensare che quattro anni prima, a St. Moritz, si era presentato ai nastri di partenza come il grande favorito, ma era caduto nella discesa libera, e tra i pali stretti dello slalom non aveva trovato né ritmo né velocità, chiudendo appena quattordicesimo. E dire che con la velocità, questo straordinario talento – nato a Cutigliano, sotto il Passo della Consuma, il 30 giugno 1920 dalla famiglia di un boscaiolo – di confidenza ne aveva.
È l’8 maggio 1947 quando Zeno, che pure sacrifica gli anni migliori sull’altare della guerra come componente della Pattuglia Sci Veloci di Cervinia, decide di dare l’assalto al record di velocità pura stabilito nel 1931 dall’austriaco Gasperl con 136,600 chilometri orari. Colò, lanciandosi sul Plateau Rosa a capo scoperto, maglione di lana, scarponi fissati agli sci da staffe e con un paio di sci di legno Cambi, stabilisce il nuovo primato con 159,291 chilometri orari. Impresa figlia di talento e ingegno: perché proprio negli anni del conflitto Zeno mette a punto una nuova posizione aerodinamica, peso centrato sugli sci, mani in avanti e schiena arcuata. Oggi questa posizione “a uovo” (perfezionata poi dal francese Vuarnet) è comune a tutti i discesisti, per i suoi indubbi vantaggi nella penetrazione dell’aria.
Il Colò che arriva quindi in Norvegia è un atleta che ha metabolizzato la delusione olimpica grazie allo straordinario campionato del mondo di Aspen, in Colorado, dove conquista gli ori in gigante e discesa e l’argento in slalom.

Ma è l’appuntamento coi cinque cerchi che stavolta non si può fallire: «La figura dell’atleta era tale che la mancanza del primato olimpionico poteva considerarsi come un attentato alla logica delle cose – scriverà G.B. Fabjan sulla prima pagina de La Gazzetta del 17 febbraio 1952 – , come un’imperfezione della natura. Il vero artista deve ineluttabilmente esprimere il suo capolavoro […]». E vero capolavoro fu, in effetti, quello che il toscano pennellò lungo il pendio di Norefjell. A cominciare, come d’abitudine, dall’attenzione maniacale per i dettagli tecnici: non a caso, infatti, si fece realizzare da un’azienda di abbigliamento la cosiddetta “guaina Colò”, una giacca da sci molto aderente al corpo, per ridurre rischio di impatti e resistenza all’aria.
La pista è in buone condizioni, al contrario della prova ufficiale, quando Zeno era caduto, causa lo scarso innevamento del percorso, ma anche per la tensione, come confesserà ai giornalisti: «[…] Ero troppo nervoso. Mi sono alzato alle sei, ho fumato una sigaretta e sono tornato a letto. Mi sentivo stanco e svogliato. […] Ma oggi mi sono svegliato calmissimo […]». E il risultato della gara lo confermerà. «La pista della discesa libera maschile – scrive Gian Maria Dossena sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di domenica 17 febbraio 1952 – partiva da un punto poco sopra la strada alta del monte, a sinistra della partenza dello slalom gigante. Correva nel gran solco tra i pini, descrivendo un’ampia curva verso destra e collegandosi nel tratto finale al percorso già utilizzato appunto per lo slalom gigante».

Preziose anche le annotazioni tecniche tecniche che seguono : «La parte alta era di normale pendenza e non difficile. Poi si rompeva in un muro piuttosto scabroso e molto ripido, e proseguiva in pericolosi sussulti, impegnativa, obbligando nella sua continua convergenza verso destra, alla mezza costa. La velocità accumulata sul muro rendeva perigliosa l’entrata nel pezzo terminale comune al gigante, e che portava al traguardo con balze che chiedevano gran rispondenza di gambe. Una pista nel complesso dura, anche se non veloce come il previsto, causa la neve riportata, quasi sabbiosa […]». Per l’azzurro c’è il pettorale numero 5; prima di lui sono scesi i suoi rivali per l’oro, l’austriaco Christian Pravda e il norvegese Stein Eriksen (che il giorno prima aveva vinto il titolo proprio in gigante), che hanno chiuso rispettivamente in 2’32”4 e 2’33”8. «Su in alto, alla partenza, il terreno non è molto ripido – conferma Colò sulla stessa pagina della rosea, in una lettera aperta a Eugenio
Monti, suo amico fraterno, asso dello sci ancor prima che del bob, fin quando un grave infortunio non costrinse il Rosso Volante (come lo aveva soprannominato Gianni Brera) a rinunciare ai Giochi di Oslo e ad abbandonare lo sci per dedicarsi esclusivamente alla sua seconda passione –; però quando ti metti lì per il “via” e davanti a te non vedi altro che la pista scapparti sotto gli occhi, e il lago che è in fondo alla valle, allora incominci a renderti perfettamente conto di cosa ti stia aspettando […]». Colò affronta la sfida col coraggio dei campioni: «Sono andato alla partenza. Io, come al solito, ho acceso una sigaretta quando il giudice mi ha detto di prepararmi e l’ho buttata sulla neve a 10” dal via. Ti assicuro che per 2’ 30” mi è sembrato di sentire come quando alla radio trasmettono una partita internazionale e un giocatore azzurro abbia appena segnato il gol della vittoria […]».

Le gambe di Zeno non tremano, anzi, si esaltano lungo il tracciato norvegese, come ben descrive ancora Dossena, raccontando l’estasi del pubblico di fronte all’apparizione di Colò nella parte visibile della pista: «Magnifico, classico nell’azione, sempre armoniosa anche nei tratti più difficili, scendeva rapido intuendo il terreno, quasi accarezzandolo con gli sci per carpirne i segreti e amicarseli. Scendeva, meraviglioso signore della neve, e il procedere facile impressionava per la scioltezza: sembrava fermo, con la pista che gli corresse sotto come un docile tappeto rotante, e solo quando balzava nel vuoto dai gobboni si vedeva il senso della sua velocità […]».
È invece la penna di Elvezio Bianchi, a pagina 4 de La Stampa di quella stessa domenica, a descriverci forse il punto tecnicamente più rilevante della prova del toscano : «Dal traguardo di arrivo della discesa di Norefjell si vedono poche centinaia di metri di un caratteristico “muro” che i norvegesi chiamano “salto”, ma che per i concorrenti fa lo stesso, si tratta pur sempre di arrivare a queste ultime centinaia di metri in grado di reggere alla formidabile picchiata che li aspetta. Questo salto finale è stato il cimitero delle speranze olimpioniche di decine di partecipanti alla gara di discesa, ma è stato anche il punto – sottolinea l’inviato del quotidiano torinese – ove Zeno Colò ha affermato la sua classe decisamente superiore di discesista. L’abetonese è spuntato dall’alto a una velocità impressionante; ha fatto una specie di atterraggio come se stesse saltando da un trampolino e ha proseguito come una freccia sul traguardo, raccolto sulle ginocchia piegate in avanti, vero proiettile umano […]». L’esito di tanta maestria è, almeno stavolta, scontato: Colò si impone in 2’30”8, eguagliando il primato della pista, davanti agli austriaci Schneider (2’32”) e Pravda (2’32”5), mentre l’idolo locale Eriksen (tra i primi a complimentarsi con l’azzurro), l’azzurro), chiude al sesto posto. È il trionfo, che emoziona i non pochi italiani presenti a Norefjell (tra cui il presidente del Coni Onesti), e l’intero Paese, che vede finalmente premiato al livello più alto uno dei suoi campioni più amati.
Da parte sua, Zeno (che torna da Oslo anche con i quarti posti in gigante e speciale) si gode la vittoria e confessa il desiderio di potersi ora dedicare alla famiglia, alla moglie e al ristorante che insieme gestiscono proprio all’Abetone. Ma a spingerlo ai margini dello sport non sarà tanto il desiderio del focolare domestico, quanto l’accusa di professionismo per aver consentito a dare il suo nome a uno scarpone e a una giacca a vento per un compenso di poco superiore al milione di lire.
La Federazione lo dissuade dal continuare l’attività agonistica, per evitare una squalifica che ne avrebbe offuscato l’immagine. Colò diventerà poi comunque accompagnatore della squadra azzurra, tecnico del settore giovanile, maestro di sci, istruttore nazionale, responsabile del centro di addestramento dell’Abetone. Si spegnerà – a causa di un cancro a un polmone, lui che era accanito fumatore – a 73 anni, nel 1993, a San Marcello Pistoiese, non prima di aver fatto in tempo, nell’aprile del 1988, a conoscere un altro figlio dell’Appennino allora fresco degli allori olimpici di Calgary, e che altri ancora ne avrebbe conquistati: Alberto Tomba.