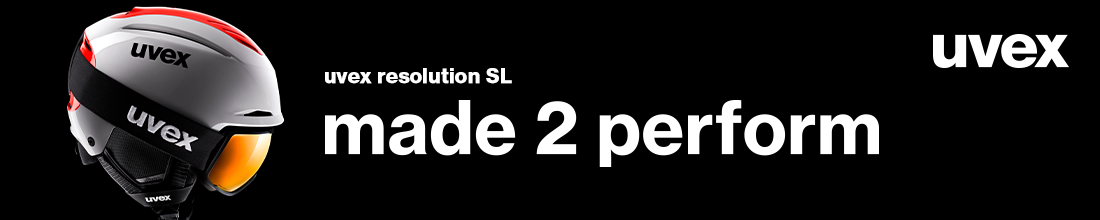«Bisognerebbe fare come in Norvegia…». Quante volte ho sentito dire questa frase da tecnici, addetti ai lavori o allenatori, parlando delle problematiche del nostro mondo giovanile nello sci. Certo, la Norvegia è una delle nazioni più forti da molte stagioni, vanta atleti spettacolari e fortemente mediatici, che si fanno sempre trovare pronti quando c’è da giocarsi una medaglia o un podio. È anche un Paese molto più ricco del nostro e la cultura degli sport invernali fa parte della tradizione popolare. Ma è la scuola norvegese a fare la differenza, il loro metodo di lavoro, oppure c’è dell’altro? Anche perché spesso e volentieri importano nostri allenatori per costruire i loro risultati. E dunque? Ci ho pensato per un po’ e quando mi gira qualcosa in testa, sono abituato ad approfondire, o almeno a provare a farlo.
Partiamo dai numeri, anche se questo tipo di analisi meriterebbe più approfondimento. Prendetelo come spunto di riflessione. Tre allenamenti a settimana, da dicembre a fine marzo. Cinque o sei run per volta, quaranta o cinquanta secondi di tracciato ciascuna. Una stima media verosimile dell’attività di uno sci club medio nella fascia di età delle scuole medie? Direi di sì.
Se facciamo i conti, un Children di uno sci club italiano percorre in una stagione tra i 100 e i 160 chilometri di scivolamento effettivo. Non è poco, ma neppure tanto, se pensiamo che ogni run dura meno di un minuto: in un allenamento di due ore, il tempo realmente trascorso all’interno del tracciato si misura in pochi minuti.
Cinque o sei run da 40-50 secondi significano in media circa quattro minuti di sci effettivo per seduta. In un’intera stagione — 50, forse 60 allenamenti — questo corrisponde a poco più di tre o quattro ore complessive di scivolamento reale, distribuite su quattro mesi di lavoro. Tradotto in media giornaliera, su un inverno di circa 120 giorni, fa meno di due minuti di azione sugli sci al giorno.

Un dato che non intende ridurre il valore dell’allenamento, ma che aiuta a misurare la quantità di esperienza motoria diretta accumulata nei tracciati: il tempo in cui il corpo è realmente in movimento, in curva, in equilibrio, in pressione. È quella la materia prima da cui nasce la sensibilità tecnica — ed è anche il punto da cui comincia il confronto con i coetanei norvegesi.
È una fotografia onesta del nostro sistema: ottima organizzazione tecnica, qualità di allenatori e materiali, ma con un vincolo strutturale — lo sci richiede logistica, impianti, trasferimenti, neve. Non è uno sport che si possa improvvisare tutti i giorni dopo scuola, come accade con il calcio o il basket nei playground.

Eppure, altrove, questo limite è stato aggirato.
Ed è proprio qui che entra in gioco il paragone con la Norvegia, dove lo sci è parte della vita quotidiana. Non serve la grande montagna né il ghiacciaio: bastano le piccole colline illuminate, presenti in quasi ogni comunità, dove i bambini possono andare a sciare subito dopo la scuola, anche solo per un’ora.
Nei documenti della Federazione Norvegese si spiega che “molti giovani sciatori si allenano o sciano per divertimento con gli amici dopo la scuola e la sera, grazie a piccole aree locali con impianti vicini e piste illuminate”. Non è un’iniziativa speciale: è la normalità. Un rapporto della federazione parla di “small local ski areas with floodlights, close to where young skiers live, allowing them to train or ski for fun after school and during the evenings”.
A Kolsås, alle porte di Oslo, esistono veri e propri programmi di “alpine school” che prelevano i bambini direttamente all’uscita dalle lezioni — verso le 14, 14.30 — per portarli sulle piste del comprensorio locale.
A Voss, molte piste restano accese di sera: alcune dedicate agli allenamenti dei club giovanili, altre aperte al pubblico, in un continuo intreccio di allenamento e gioco.
In altri casi, la scuola stessa integra lo sport nella routine: diversi studi norvegesi raccontano come “gli studenti praticano attività sportiva cinque o più giorni alla settimana”, con orari scolastici flessibili per consentire “allenamento o sci durante o subito dopo le lezioni”.
La filosofia è coerente: “tanti giri, tanti salti, blocchi brevi e intensi”. L’obiettivo è che i bambini vivano la neve ogni giorno, con continuità, sviluppando un rapporto naturale con l’ambiente e con il gesto tecnico.

Gli aneddoti dei campioni norvegesi raccontano, meglio di qualsiasi documento, quanto quella quotidianità sulla neve faccia parte del loro DNA sportivo.
Henrik Kristoffersen, cresciuto nel club di Rælingen, a pochi minuti da casa, ha ricordato più volte che «la mia infanzia è stata tutta al Marikollen, la collina dietro la scuola. Potevamo sciare ogni giorno, anche di sera, con le luci accese». In un’intervista ha aggiunto: «Dopo la stagione di Coppa del Mondo sono tornato a scuola, ma ho continuato a sciare fino a metà maggio».
Kjetil André Aamodt, leggenda di Oslo e figlio di un allenatore, ricorda gli allenamenti con il padre Finn: «Credeva che il lavoro sistematico portasse risultati, anche da bambini. Ci faceva alzare presto e ci teneva tardi sulle piste». Il suo racconto riassume lo spirito norvegese: nessuna eccezionalità, solo costanza e prossimità alla neve.
Anche Aksel Lund Svindal ha spesso spiegato come la forza del suo Paese non stia nel talento individuale, ma nel contesto: «È un ecosistema che si autoalimenta. Cresci in un ambiente in cui tutti sciano, dove è normale passare pomeriggi in pista con gli amici. Non vuoi uscirne, e senza accorgertene accumuli migliaia di ore di esperienza».
Kjetil Jansrud, cresciuto nella valle di Gudbrandsdalen, racconta un’infanzia a Hafjell fatta di sveglie all’alba: «Le cinque del mattino ripagano sempre. Facevamo qualche run prima di scuola, poi ancora il pomeriggio. È così che impari a sentire la neve».

È un filo comune che attraversa generazioni di atleti: lo sci come abitudine quotidiana, non come evento programmato. Una cultura che trasforma il pendio dietro casa in un laboratorio tecnico, e l’inverno in un tempo continuo di gioco, disciplina e libertà.
È un ambiente che invita alla ripetizione quotidiana, anche minima ma costante. Non è detto che tutti i bambini norvegesi passino tre o quattro ore al giorno sugli sci, ma la possibilità di farlo — spesso a pochi minuti da casa — crea un volume di esposizione che in Italia semplicemente non esiste.
«Mi allenavo continuamente. Mi veniva naturale. Lo facevo in automatico e non ho mai avuto la sensazione di fare sacrifici per sciare. Simen e io tornavamo da scuola prima che il papà rientrasse dal lavoro. Da noi vigeva la regola che i compiti dovevano essere finiti prima che varcasse la soglia di casa, in modo tale da permetterci di andare subito all’allenamento. Quando rincasavamo la sera, spesso verso le dieci, non c’era altro da fare se non cenare e andare dritti a letto». Lo scrive Aksel Lund Svindal nella sua autobiografia Più grande di me che abbiamo pubblicato nella nostra collana Circo Bianco e che vi invito assolutamente a leggere. Parla della sua quotidianità: tutti i giorni, all’età delle scuole medie, per lui era così.

Insomma, la differenza è culturale e infrastrutturale.
Da noi lo sci è un impegno che si pianifica: orari, trasferte, skipass, allenamenti organizzati. In Norvegia è una pratica spontanea, accessibile e diffusa. Così, mentre un ragazzo italiano accumula qualche centinaio di chilometri l’anno concentrati in poche settimane, il suo coetaneo norvegese moltiplica le occasioni: piccole dosi quotidiane che, stagione dopo stagione, costruiscono una base motoria e tecnica immensamente più ampia.
È lo stesso principio alla base di generazioni di calciatori brasiliani cresciuti giocando ore e ore sulla sabbia o di cestisti americani nati nei playground: il vantaggio non è genetico, ma di contesto. Quando lo sport è parte della vita di tutti i giorni, il talento cresce dentro una quantità enorme di esperienze, gesti, errori, intuizioni.
Ed è qui che torna utile ricordare la famosa “regola delle 10.000 ore”.
Il concetto nasce dalle ricerche dello psicologo svedese Anders Ericsson, docente alla Florida State University, che studiò il percorso di violinisti, musicisti e atleti d’élite. La sua tesi — poi semplificata e resa popolare da Malcolm Gladwell — è che per raggiungere l’eccellenza servano in media circa diecimila ore di pratica deliberata: non semplice esercizio, ma allenamento intenzionale, mirato, con obiettivi chiari e feedback costante.
Ericsson non parlava di una soglia magica, ma di un metodo: ciò che conta non è quante ore si fanno, ma come le si fanno. Tuttavia, per arrivare a quel livello di approfondimento tecnico, serve comunque un grande volume di esperienze, di tentativi, di correzioni.

E in questo senso, la differenza tra Italia e Norvegia diventa evidente.
La qualità della didattica può essere la stessa, ma il contesto norvegese permette di accumulare quantità: più giorni, più ore, più situazioni. Alla fine del percorso scolastico, quando i ragazzi delle due nazioni si ritrovano nelle categorie internazionali giovanili, i norvegesi arrivano con un bagaglio di sci e di esperienza sulla neve nettamente superiore.
Non perché abbiano allenatori migliori o condizioni più facili — ma perché hanno più tempo reale di sci, fin dall’infanzia.
In realtà, quando si parla di modello norvegese, non ci si riferisce a un sistema progettato a tavolino, ma a un ecosistema che funziona per stratificazione.
La federazione è solida, organizzata, ricca, ma il suo vero capitale è sociale: una rete radicata nei territori, piste accessibili, una cultura che considera lo sci un’estensione della scuola e della famiglia. È questo che crea la base larga su cui poi il sistema tecnico può costruire l’eccellenza.
Il “modello” non nasce nei piani alti, ma dal basso: dalla somma di migliaia di piccoli gesti quotidiani, di ore rubate alla luce, di comunità che si riconoscono sulla neve.
La federazione, in questo senso, non inventa i campioni: li fa crescere in un ambiente già fertile.

Allora, quando qui da noi ci si interroga sul famoso ‘modello norvegese’ bisognerebbe guardarsi in faccia e capire, tante cose. Volete sapere la prima che mi viene in mente?Come mai i valligiani non sciano più? Come mai nelle località sciistiche i tesserati ai club sono per il 70-80 e volte anche 90% cittadini che possono sciare solo qualche ora nel weekend? Come mai i ragazzi dei paesi di montagna giocano sempre di più a basket, a calcio, a pallavolo o a tennis?
Perché stiamo svuotando questo sport del suo bacino naturale, della sua appartenenza più logica e territoriale? Ovvio che non si devono creare favoritismi, ma le attuali dinamiche hanno fatto sì che le porte siano rimaste chiuse in faccia alle famiglie montanare. Prezzi impossibili, richiesta agonistica eccessiva. Scelte e strategie che puntano solo al profitto e non al sociale?
Non abbiamo la conformazione del territorio, la temperatura, le neve che c’è in inverno in Norvegia anche a basse quote. Ma forse, se i ragazzi di montagna ricominciassero ad andare a sciare, come sulle collinette norvegesi, ore e ore al giorno, il bacino di potenziali talenti potrebbe tornare a salire, non perché siano migliori degli altri ragazzi, semplicemente perché hanno la neve sotto casa. Per fare esperienza, per fare quantità, per creare schemi motori con confidenza e naturalezza.
Andando avanti così, finiremo che nel circuito FIS, quando si ritrovano al cancelletto, i nostri ragazzi e i loro coetanei norvegesi non partiranno da basi tecniche differenti, ma da esperienze diverse. Noi contiamo le discese, loro le vivono. E alla fine, la differenza si vede.