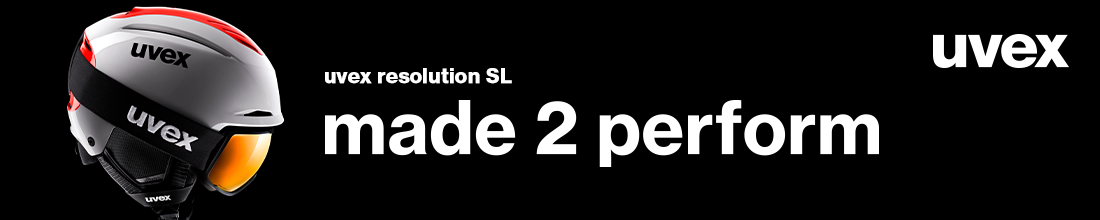Alla vigilia del primo slalom della stagione di Coppa del Mondo, ho provato a fare una riflessione sullo stato della disciplina in Italia, sul livello delle nostre squadre e sulle reali possibilità di Vinatzer, Sala & C. a Levi, ma anche in prospettiva olimpica, aprendo lo sguardo su ciò che è stato fatto in passato e su ciò che succede negli altri Paesi. Sgombriamo il campo da equivoci: siamo i primi tifosi dei ragazzi con la tuta azzurra, ma non possiamo negare le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti in questa disciplina. Poi, nello slalom può succedere di tutto, con l’inversione dei 30 nella seconda manche le sorprese sono dietro l’angolo, e sarei lieto di essere smentito, ma a mio giudizio sarebbe più un episodio che una reale dimostrazione di forza. Se ci limitiamo ai risultati delle ultime stagioni, la nostra squadra non è sicuramente tra quelle che a Levi sono attese sul podio o in lotta per la vittoria. E non parlo del settore femminile, in cui persiste un’anomalia forse senza eguali per le nazionali di vertice, con le nostre atlete fuori dalle big oramai da due lustri o più. Parlo del settore maschile, dove per anni abbiamo saputo essere grandi protagonisti e ora rischiamo di fare da contorno ai reali protagonisti.
Siamo diventati una squadra di serie B, e non ci siamo nemmeno accorti di quando questo sia avvenuto.
Eppure c’è stato un tempo in cui lo slalom era la grammatica madre dello sci italiano.
Non solo la disciplina in cui eccellevamo, ma il contesto in cui si costruiva il modo stesso di sciare: equilibrio, ritmo, pulizia, centralità.
Oggi, però, guardando una manche di Coppa del Mondo, si percepisce un cambio di paradigma: il mondo corre su un’altra frequenza.
E noi, che quella lingua l’avevamo inventata, sembriamo parlarla con un accento antico.
Negli anni Settanta, quando Gustav Thöni e Piero Gros dettavano la legge tra paletti di legno con le bandierine e ghiaccio vivo, l’Italia rappresentava un laboratorio tecnico riconosciuto. Gli anni di Mario Cotelli, della Valanga azzurra e del dominio degli slalomisti nostrani.
Lo slalom era la nostra specialità genetica: la sintesi perfetta tra eleganza e controllo, tra forza e sensibilità.
Leonardo David, con la vittoria a Oslo nel 1979, fu l’anello di congiunzione tra quella generazione e il futuro.
Poi arrivò Alberto Tomba, e la curva italiana divenne un fenomeno globale.
Le sue vittorie tra il 1987 e il 1998 ridefinirono il gesto tecnico.
Tomba trasformò la disciplina in spettacolo e scienza insieme: peso centrato, traiettoria disegnata come un’equazione, preparazione fisica evoluta e utilizzo della forza, in anticipo con i tempi.
Eravamo noi, allora, a indicare la strada.

In quell’epoca arrivarono Fabrizio Tescari, vincitore a Sestriere nel 1992, Konrad Kurt Ladstaetter, Fabio De Crignis, Angelo Weiss (Chamonix 2000), Matteo Nana (Beaver Creek 2000).
Una generazione compatta, non sempre da podio ma stabile e presente: l’Italia c’era, sempre.
Poi, dal 2002 in avanti, Giorgio Rocca riportò il tricolore al vertice con una serie di successi che culminarono nella Coppa di specialità 2006 e che per circostanze sfortunate non culminarono con un oro olimpico a Sestriere.
Era l’ultima volta in cui il nostro sistema tecnico produceva un dominatore.
Negli anni successivi, la presenza italiana si è fatta più episodica.
Cristian Deville vinse a Kitzbühel nel 2012, Patrick Thaler centrò due podi nel 2013–14, Stefano Gross e Manfred Moelgg mantennero alta la bandiera fino al 2017, Giuliano Razzoli (campione olimpico a Vancouver nel 2010) prolungò la sua parabola fino al podio di Wengen nel 2022.
Infine, Alex Vinatzer, oggi il nostro nome di riferimento, con i podi di Zagabria e Madonna di Campiglio nel 2020 e il secondo posto a Kitzbühel nel gennaio 2025.
Sono risultati che testimoniano vitalità, ma anche una costante: la distanza temporale tra un successo e l’altro si è allungata.
Quello che un tempo era una catena continua di eccellenze è diventato un mosaico di momenti isolati, sempre più sporadici.

Nel linguaggio dello sport, vent’anni equivalgono a un’era.
E se la memoria collettiva ci restituisce ancora le immagini di Rocca o Tomba come ieri, nel ritmo reale della competizione siamo già due generazioni oltre.
Lo slalom, intanto, ha cambiato pelle: attrezzatura, tracciati, pendenze, ritmo.
È diventato una disciplina in cui la componente atletica e la gestione della forza determinano la performance probabilmente di più della qualità tecnica.
E mentre il mondo si evolveva, il nostro modello è rimasto sostanzialmente fedele a se stesso.
Questo non significa che in Italia si scii male.
Anzi, la scuola italiana resta sinonimo di competenza e qualità del gesto.
Ma sembra prevalere una mentalità ancorata a un modello tecnico che, fino a pochi anni fa, bastava a produrre risultati di vertice.
Oggi non più.
Le altre nazioni hanno integrato in modo sistematico elementi che da noi restano ai margini: la misurazione oggettiva del carico, la lettura dei materiali come leva prestativa, la forza eccentrica come prerequisito tecnico.
Ho l’impressione che dove noi cerchiamo la sciata pulita, gli altri ricercano la curva efficiente: quella che restituisce energia al momento giusto.
In questo senso, il nostro ritardo non è culturale, è metodologico.
Sembra che non abbiamo rinnovato la catena tecnica alla luce della nuova biomeccanica della curva: il modo in cui si carica lo sci, il timing della pressione, la relazione tra angolo, velocità e risposta elastica.
Gli altri sistemi tecnici lo hanno fatto, spesso importando competenze da altri sport — atletica, ginnastica, sollevamento pesi, perfino discipline di combattimento per la gestione delle forze eccentriche.
Paradossalmente, mentre ci guardiamo allo specchio e ci riconosciamo poveri di atleti sia in campo maschile che femminile, lo slalom resta la disciplina più allenabile e democratica dello sci alpino.
Richiede meno logistica, meno risorse e permette un volume di lavoro altissimo.
Basta un fazzoletto di pista, un tracciato ben disegnato e idee chiare.
È la specialità in cui la qualità dell’allenamento conta più della quantità di mezzi.
Non serve una pista chiusa, non servono reti chilometriche o staff di dieci persone per gestire l’allenamento.
Serve una visione tecnica, un metodo e un obiettivo.
La discesa libera è la Formula 1 dello sci: richiede strutture, sicurezza, personale e budget enormi.
Lo slalom, al contrario, è un laboratorio accessibile, dove la sensibilità e la ripetizione fanno la differenza.
Proprio per questo è anche la disciplina in cui le piccole nazioni riescono a emergere.
Lo slalom, per sua natura, non appartiene solo alle grandi montagne.
È la disciplina più allenabile dello sci perché vive di spazio limitato, di neve compatta, di ripetizioni.
E infatti, in questi ultimi anni, le nazioni che hanno saputo crescere — anche senza un sistema di montagne imponente — sono quelle che hanno imparato a controllare l’ambiente più che a dominarlo.
La Gran Bretagna, con Dave Ryding, è l’esempio più chiaro: un movimento microscopico, nato nei capannoni e nei pendii artificiali del nord d’Inghilterra, che ha costruito competitività attraverso il metodo, non attraverso le montagne.
Allenamenti indoor, volumi brevi ma costanti, staff piccoli e preparati.
Una struttura essenziale che ha saputo massimizzare il tempo utile e isolare le variabili.
Ryding non è un miracolo: è il risultato di un sistema che ha accettato i propri limiti e li ha trasformati in specializzazione.

Ma possiamo spingere lo sguardo più in là, in una veloce panoramica che ci aiuti a capire come la cultura di questa disciplina sia uscita dai confini di Austria, Svizzera, Italia e Francia. La Norvegia ha fatto delle microstazioni dei veri laboratori di precisione, basati su qualità e sicurezza; la Finlandia ha trasformato la mancanza di montagne in un vantaggio, sfruttando neve artificiale e allenamenti ad altissima densità. Negli Stati Uniti, invece, la forza nasce dalla frammentazione: college, club e comprensori locali formano un arcipelago di eccellenze dove la cultura del lavoro supplisce alla mancanza di un sistema centrale.
Paesi diversi, stessi principi: ripetizione, qualità del gesto, conoscenza dell’attrezzo. Hanno capito che la quantità di neve non conta quanto la capacità di trasformarla in metodo.
Se guardiamo verso est, troviamo un’altra lezione. Croazia, Slovenia, Serbia e, più a nord, la Slovacchia, hanno costruito negli ultimi decenni una scuola slalomistica solida, coerente e sorprendentemente sofisticata. La loro forza non nasce dalle infrastrutture, ma da un atteggiamento mentale e tecnico: lo sci come disciplina, non come spettacolo.

La famiglia Kostelić ne rappresenta il simbolo e la matrice. Ante, ex atleta di pallamano, maestro dello sport della scuola jugoslava, e poi allenatore di sci per passione, trasformò la mancanza di mezzi in una filosofia. La sua teoria — affinata negli anni Novanta, quando Janica e Ivica si allenavano tra le nevi sporche di Sljeme o sulle strade d’estate — si basava su un principio essenziale: allenare la resistenza al limite, non solo la forza.
I suoi metodi erano radicali: carichi di lavoro estremi, lunghi allenamenti a bassa intensità, esercizi di equilibrio e coordinazione mutuati da altri sport, viaggi in barca per costruire resistenza mentale.
Ante Kostelić non cercava la curva perfetta, ma l’atleta capace di resistere all’imperfezione.
I risultati, poi, gli hanno dato ragione: Janica, quattro ori olimpici e cinque Coppe del Mondo di specialità tra il 2001 e il 2006, è stata la più completa sciatrice della sua epoca; Ivica, tre volte vincitore della Coppa del Mondo di slalom (2002, 2011, 2013) e campione olimpico, ha incarnato la precisione biomeccanica applicata alla sopravvivenza agonistica.

Da quella filosofia è nata una generazione di allenatori itineranti, oggi sparsi in tutto il mondo, che portano con sé l’idea di una curva come esercizio di sopravvivenza controllata, in cui il gesto tecnico è subordinato alla gestione mentale e fisica dello sforzo.
Accanto alla Croazia, la Slovenia ha costruito la propria tradizione con radici ancora più profonde. Già negli anni Ottanta, Bojan Križaj e Rok Petrovič avevano portato lo slalom jugoslavo ai vertici mondiali, anticipando per eleganza e timing molti dei concetti che oggi consideriamo moderni. Petrovič, in particolare, introdusse una sciata analitica e spigolosa, quasi scientifica, basata sul controllo dell’asse corporeo e sull’uso progressivo dell’angolo: fu un innovatore, un tecnico puro prima ancora che un atleta.
Negli anni successivi, la scuola slovena ha mantenuto questa doppia anima — rigore tecnico e libertà individuale — fino ad arrivare a campioni come Tina Maze, capace di trasformare la precisione in potenza, o Žan Kranjec e Andreja Slokar, che ne rappresentano oggi la continuità naturale.

Questo asse balcanico, nato tra confini e economie minime, ha dimostrato che nello slalom non serve possedere la montagna per dominarla. Serve conoscerla, accettarla, e farne laboratorio. È un modello fondato sulla competenza più che sulla struttura, dove la cultura del limite diventa risorsa tecnica. E mentre le grandi nazioni discutono di budget e impianti, in queste piccole scuole continua a vivere l’idea più pura dello slalom: la curva come misura dell’uomo, prima ancora che della velocità.
In fondo lo slalom vive della possibilità di ripetere e la ripetizione richiede spazi controllati, tempi certi, neve affidabile.
Per questo le nazioni che oggi crescono hanno investito anche in piste dedicate e strutture indoor: non impianti monumentali, ma piccoli tratti di pista chiusi e gestiti come palestre. Neve artificiale, sicurezza garantita, turni brevi, manutenzione costante.
Sono ambienti che non rubano spazio al turismo: lo separano.
È la differenza che passa tra nuotare al mare e allenarsi in piscina: il mare è tempo libero, la piscina è sport e in ogni grande città di mare c’è una piscina coperta, perché serve all’agonismo.
Allo stesso modo, anche le località turistiche più importanti dovrebbero avere spazi tecnici dedicati all’allenamento.
Non tolgono risorse: aggiungono cultura sportiva.

Gli ski dome in Europa — Olanda, Gran Bretagna, Germania, Norvegia, Finlandia — funzionano proprio così: sono palestre di neve, luoghi dove si allena il gesto, dove si bada al sodo.
Dentro uno ski dome, ogni curva è identica alla precedente: stesso grip, stessa temperatura, stessa pendenza.
È l’ambiente ideale per consolidare il timing e la sensibilità, per testare materiali, per radicare la memoria motoria.
Soprattutto, è il modo più efficace per coprire i vuoti stagionali: quando in Italia si aspetta la neve o si spende in trasferte, altrove si scia tutti i giorni.
In Italia, invece, il tema è ancora trattato come un tabù politico.
Lo ski dome viene visto come un’infrastruttura che toglie turismo, anziché come un impianto sportivo.
Ma lo sci agonistico non vive del turista: vive di chilometri di scivolamento fatti bene.
Uno ski dome non sostituisce la montagna, la integra.
Permette a giovani e club di pianura di allenarsi tutto l’anno, di ridurre i costi di viaggio, di migliorare la qualità del lavoro.
Non è un sogno, è un passaggio culturale: come accettare che la piscina serve al nuoto agonistico, non alla tintarella e al bagnasciuga.
In tal senso l’Olimpiade Milano-Cortina avrebbe potuto rappresentare la grande occasione di ripartenza.
Cinque anni fa era il momento giusto per costruire un percorso dedicato, un piccolo gruppo selezionato di atleti — quattro o cinque uomini e altrettante donne — da accompagnare con continuità fino all’appuntamento olimpico.
Non serviva un miracolo, solo coerenza: staff stabili, programmazione pluriennale, obiettivi chiari.
Un progetto semplice, ma chiuso, protetto dalle oscillazioni di forma (e di risultati) e dalle pressioni esterne.
Non è accaduto: le scelte sono rimaste stagionali, talvolta episodiche, con staff che cambiano, visioni che si alternano e linee tecniche che raramente resistono più di due inverni.
Il risultato è che, oggi, arriviamo ai Giochi di casa senza una squadra di riferimento nello slalom, la disciplina che più di ogni altra ci rappresentava.
Un’occasione mancata, che fotografa bene l’attuale disallineamento tra ambizione e struttura.
Alla base di tutto questo, volendo andare più a fondo, c’è anche un fattore meno tecnico e più organizzativo.
Il sistema delle squadre nazionali giovanili è ancora condizionato da logiche di rappresentanza territoriale.
I Comitati regionali, che esprimono voti e potere all’interno della FISI, pretendono visibilità e presenza nei gruppi delle squadre nazionali. Stesso discorso, a cascata, che vale per i grandi club che dispongono di importanti pacchetti di voti e deleghe nella logica di un sistema che elegge i propri rappresentanti in modo medievale.
È una dinamica antica, ma ancora attiva: spesso le scelte tecniche si piegano agli equilibri politici, e la meritocrazia diventa negoziazione.
Il risultato è una struttura frammentata, con continui cambi di rotta e scarsa continuità metodologica.

In altri Paesi, anche con federazioni più piccole, accade l’opposto: prima si costruisce un progetto tecnico, poi si decide chi lo guida.
Da noi, spesso, le persone vengono prima del progetto.
E ogni volta che si ricomincia, si disperdono mesi di lavoro, risorse e fiducia.
Guardando la cronologia dei nostri risultati, la tendenza è chiara: dagli anni di Tomba e Rocca, quando gli italiani monopolizzavano i podi, a un decennio in cui i piazzamenti si contano sulle dita di una mano.
È un ciclo naturale, ma anche un segnale di un modello che ha smesso di evolversi e mentre le altre scuole hanno accelerato, noi abbiamo mantenuto il passo di ieri.
Nel mondo dello sport, dove ogni stagione riscrive i parametri, vent’anni equivalgono a un secolo.
Non serve negarlo: serve capirlo.
Oggi non abbiamo perso la nostra identità, ma rischiamo di non riconoscerci più nel contesto attuale.
Perché mentre noi difendiamo la correttezza di un gesto, gli altri studiano come trasformarlo in energia utile al cronometro.
Non è un giudizio, è una constatazione.
E forse il primo passo per tornare competitivi sta proprio qui: nel riconoscere che la nostra tradizione non deve essere abbandonata, ma tradotta in una lingua che il mondo moderno capisce.
Lo slalom, più di ogni altra disciplina, ci somiglia: tecnico, meticoloso, esigente, ma ancora profondamente umano.
E come noi, oggi, deve scegliere se restare fedele alla propria forma o ritrovare la propria sostanza.